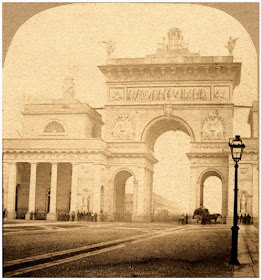Galeazzo Maria nacque a Fermo il 14 gennaio 1444, alle ore 21, primogenito di una delle coppie più determinanti per la storia milanese, convolata a nozze il 24 ottobre 1441: Bianca Maria Visconti, ultima discendente legittimata della casata che aveva governato la città per quasi due secoli, e Francesco Sforza, primo signore di Milano ad appartenere ad una nuova dinastia, che, terza in ordine di tempo, deciderà le sorti cittadine prima dell’inizio dei lunghi domini stranieri.
All’ombra del padre
Il piccolo Galeazzo fece il suo arrivò a Milano all’età di
sei anni, quando, in braccio alla madre, trionfalmente la città festeggiava e
salutava, quale nuovo signore, il padre Francesco Sforza. A tredici anni venne
mandato da Borso d’Este, con un folto seguito di medici e precettori, per
intraprendere gli studi degni di un futuro duca: lettere italiane, francesi e
latine; filosofia, musica, arte, matematica e scienze dei cieli. Senza
naturalmente dimenticare le importanti lezioni per diventare un provetto
cavallerizzo, cacciatore, danzatore. All’arte della guerra, preferì pensarci
direttamente il padre, all’epoca vero ed indiscusso maestro.
 La vita sentimentale di Galeazzo Maria doveva inizialmente
prendere una svolta con il matrimonio combinato con Susanna Gonzaga, casata
alla quale Francesco Sforza molto doveva per i fatti d’arme contro i Veneziani,
ma il tutto naufragò a causa di insormontabili difetti fisici della sposa (la
poveretta era gobba, come del resto molti membri della famiglia Gonzaga, e finì
con l’andare in convento). Neppure il secondo tentativo con la sorella minore
di Susanna, Dorotea, andò in porto: stavolta ci si mise lo stesso Francesco
che, mutata la condizione politica, non aveva più interesse ad imparentarsi con
i signori di Mantova, ormai reputata capitale di uno staterello prettamente
agricolo. Così, venne fatta passare per gobba anche Dorotea (che a dire delle
cronache, gobba non era, ma che abili visite mediche “di parte” descrissero
come destinata alla gibbosità), la quale morì poi alla giovane età di 23 anni.
La vita sentimentale di Galeazzo Maria doveva inizialmente
prendere una svolta con il matrimonio combinato con Susanna Gonzaga, casata
alla quale Francesco Sforza molto doveva per i fatti d’arme contro i Veneziani,
ma il tutto naufragò a causa di insormontabili difetti fisici della sposa (la
poveretta era gobba, come del resto molti membri della famiglia Gonzaga, e finì
con l’andare in convento). Neppure il secondo tentativo con la sorella minore
di Susanna, Dorotea, andò in porto: stavolta ci si mise lo stesso Francesco
che, mutata la condizione politica, non aveva più interesse ad imparentarsi con
i signori di Mantova, ormai reputata capitale di uno staterello prettamente
agricolo. Così, venne fatta passare per gobba anche Dorotea (che a dire delle
cronache, gobba non era, ma che abili visite mediche “di parte” descrissero
come destinata alla gibbosità), la quale morì poi alla giovane età di 23 anni.
Il giovane Galeazzo venne allora promesso in sposo alla
giovane Bona di Savoia, sorella di Carlotta di Savoia, seconda moglie del re di
Francia Luigi XI: una parentela decisamente ambita, quella col re di Francia,
che Francesco volle guadagnarsi a tutti i costi, tant’è che mandò in soccorso
del re, nel 1465 sotto l’assedio di feudatari ribelli, il proprio esercito
capitanato dal primogenito Galeazzo. Non fu una grande impresa militare, anzi,
per Galeazzo sembrava inventata apposta per dargli, sulla scena internazionale,
quella fama militare che ancora non aveva. Pochissimi pericoli, e un buon
numero di capitani sforzeschi pronti a difenderlo e ad assumersi i rischi veri.
Ma tant’è, fu un successo sforzesco, e una grande entrata in scena del
ventunenne erede del ducato di Milano. Che però, proprio ai massimi trionfi in
suolo francese, fu informato della morte del padre, spentosi l’8 marzo del
1466. Fu una vera fortuna, e una vera impresa, il riuscire a rientrare a
Milano, dopo l’agguato subito alla Novalesa, nei pressi di Susa, a causa della
sua inimicizia con Amedeo IX.
Il quinto duca di Milano
Il 20 marzo il nuovo signore della città fece trionfale
ingresso (secondo l’organizzazione della madre) da Porta Ticinese, in un vero
tripudio di popolo.
Negli anni successivi concluse gli accordi per il suo
matrimonio con Bona: questa avrebbe portato in dote 100.000 ducati d’oro, e il
giovane duca, dal canto suo, si impegnava a costituire una controdote di 15.000
ducati d’oro all’anno, da pagarsi alla sposa grazie alle nuove tassazioni da
applicare alle città di Pavia, Piacenza, Parma e Como.
Celebrate le nozze per procura il 10 maggio 1468, la novella
sposa sbarcò a Genova nel luglio seguente, e ad accoglierla Galeazzo inviò il
fratello Ludovico Maria (proprio il Moro che poi prenderà il potere). Le nozze
verranno ratificate in Duomo il 7 luglio, poco più di tre mesi prima che
morisse la madre Bianca Maria, condannata dal figlio a ritirarsi a Cremona, suo
feudo dotale, ma in realtà morta lungo la strada per arrivarci, dalle parti di
Melegnano.
Dal matrimonio sarebbero nati quattro figli, anche se
Galeazzo ne ebbe molti di più, essendo famoso per la sua plateale infedeltà,
come vedremo tra poco.
 Il Duca di Milano amava spendere gran quantità di denaro per
circondarsi di lusso e bellezza, e della sua passione se ne giovò
prevalentemente il Castello, più volte sottoposto a restauri e a innovazioni,
quali la loggetta che si affaccia sulla corte ducale, e alla quale si accede
attraverso la comodissima scala a gradoni lunghi, così voluta per poterla
percorrere direttamente in sella al cavallo.
Il Duca di Milano amava spendere gran quantità di denaro per
circondarsi di lusso e bellezza, e della sua passione se ne giovò
prevalentemente il Castello, più volte sottoposto a restauri e a innovazioni,
quali la loggetta che si affaccia sulla corte ducale, e alla quale si accede
attraverso la comodissima scala a gradoni lunghi, così voluta per poterla
percorrere direttamente in sella al cavallo.
Tra i meriti politici e amministrativi, si suole ricordare
una intelligente pavimentazione delle strade di Milano con blocchi di pietra,
voluta e realizzata in tempo da record nel 1470, ma anche progetti di più ampio
respiro, come l’introduzione dell’arte della stampa, per amore della quale
finanziò la tipografia di Panfilo Castaldi e di Antonio Zaroto (arte che a
Milano trovò fertile terreno, tanto da renderla capitale dell’editoria), della
coltivazione del riso (ne mandò in dono dodici sacchi ad Ercole d’Este), del
gelso (gli alberi di “moroni”) e della seta (già compresa, nella sua
importanza, dal nonno Filippo Maria Visconti). Rese navigabili la Martesana e
quella parte di naviglio pavese tra Pavia e Binasco. Si occupò anche della
condizione dei suoi sudditi, cercando (per quanto era concepibile all’epoca) di
risolvere i problemi legati all’insalubrità di certi mestieri. Si preoccupò di
introdurre un sistema di censimento e anagrafe su base civile e non più
ecclesiastica. Suo anche il merito, negli ultimi anni di governo, di aver
riordinato il sistema delle emissioni monetarie della Zecca di Milano,
rinnovandone i nominali e curando particolarmente la purezza della lega. Le
denominazioni delle monete diventarono quanto mai varie (ed ancora oggi, per
noi, di difficile interpretazione): il ducato, o zecchino d’oro, il grosso, il
testone, il doppio testone, il soldo, il sesino, la trillina, ecc ecc.. Decise
anche di spostare l’edifico della Zecca, che lasciò così la sua collocazione
risalente all’epoca romana presso la chiesa di San Mattia alla Moneta (attuale
via Moneta) per risorgere, ingrandita e meglio attrezzata, nella strada
adiacente, oggi battezzata Zecca vecchia.
Nella primavera del 1471, con la moglie Bona, scese con un
seguito principesco (si dice, anche con buffoni, scimmie e pappagalli da
divertimento) a Firenze, quasi a sfidare Lorenzo, il Magnifico.
Divenne anche famoso per il gran numero di amanti
collezionate, di tutte le estrazioni, anche se con quelle di rango sapeva
essere alquanto riconoscente: a Lucia Marliani, che a Milano abitava nella
parrocchia di San Giovanni sul Muro e che fu sempre fatta passare per l’amante
del fratello Ludovico (affinché Bona non ne soffrisse troppo), regalò le
entrate fiscali del Naviglio Martesana, e nel dicembre 1474, il ricco feudo di
Melzo con annesso castello.
D’altro canto, Galeazzo era un uomo spesso crudele e
malvagio coi propri nemici, e soprattutto molto impulsivo. Ammetteva di essere
eccessivamente “lussurioso e “pomposo”, ma smorzava il vizio auto-assolvendosi
sostenendo che, del resto, non è gran peccato, in un signore, l’essere superbo.
La sua vita, a molti così invisa, durò comunque poco: il 26
dicembre 1476 (gli mancava meno di un mese a compiere trentatrè anni), fu
ucciso da una congiura organizzata, si disse, con la finalità di sollevare il
popolo, o forse, imbastita dallo stesso re di Francia assetato di espandere i
propri domini.
L'assassinio
Il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, Galeazzo volle
assistere alla messa mattutina recandosi presso la chiesa di Santo Stefano. Del
resto, il giorno precedente, Natale, alle tre messe aveva preso parte rimanendo
al sicuro nella Cappella Ducale.
Nonostante fosse scortato da fedeli soldati, l’agguato fu
repentino e del tutto inaspettato. Appena il duca mise piede sotto il portico
della chiesa (portico ora scomparso, ma presente fino almeno alla metà del
1600; oggi una lapide ivi murata ricorda l’evento) tre congiurati, Giovanni
Andrea Lampugnani, Gerolamo Olgiati, e Carlo Visconti, gli furono addosso coi rispettivi pugnali.
 L’assalto fu descritto da Orfeo Cenni da Ricavo, consigliere
e amico del duca, quella mattina in veste di accompagnatore: “Essendo nel mezzo
della chiesa quello traditore di Giovanni Andrea li misse tutto il pugnale nel
corpo. El povero signore si li misse le mani e disse: Io son morto! Illo ed
eodem stante, lui reprichò l’altro colpo nello stomacho; li altri dua li
dierono quatro colpi: primo nella ghola dal canto stancho, l’altro sopra la
testa stancha, l’altro sopra al ciglio nel polso, el quarto nel fiancho di
drieto, e tutti di pugnali. E questo fu inn un baleno e uno alzare d’aocchi, e
chosì venne rinculando indrieto, tanto che quasi mi diè di petto. E veniva
traboccando, e io lo volsi sostenere, ma non fui chosì presto che ‘l cascò a
sedere e poi riverso tutto. E dua di quelli traditori non lo abandonaron mai
per insino che fu in terra”.
L’assalto fu descritto da Orfeo Cenni da Ricavo, consigliere
e amico del duca, quella mattina in veste di accompagnatore: “Essendo nel mezzo
della chiesa quello traditore di Giovanni Andrea li misse tutto il pugnale nel
corpo. El povero signore si li misse le mani e disse: Io son morto! Illo ed
eodem stante, lui reprichò l’altro colpo nello stomacho; li altri dua li
dierono quatro colpi: primo nella ghola dal canto stancho, l’altro sopra la
testa stancha, l’altro sopra al ciglio nel polso, el quarto nel fiancho di
drieto, e tutti di pugnali. E questo fu inn un baleno e uno alzare d’aocchi, e
chosì venne rinculando indrieto, tanto che quasi mi diè di petto. E veniva
traboccando, e io lo volsi sostenere, ma non fui chosì presto che ‘l cascò a
sedere e poi riverso tutto. E dua di quelli traditori non lo abandonaron mai
per insino che fu in terra”.Questa circostanziata descrizione, seppur bisognosa di interpretazione, ci rappresenta bene la violenza e la rapidità dell’azione, così inaspettata da rendere impossibile o comunque vana ogni difesa, sia da parte del Duca, sia da parte degli uomini a lui fedeli che lo attorniavano in quella uscita pubblica.
I colpi inferti al Signore di Milano, infatti, anche se
sferzati di fretta e col timore di un immediato arresto, risultarono in più
casi mortali.
Partendo dalla narrazione coeva appena vista, e da studi
successivi, Francesca Vaglienti (vedi bibliografia in calce) ha ricostruito nei
minimi dettagli quella che oggi chiameremmo la scena del delitto.
Dunque, il primo congiurato a colpire Galeazzo fu il
Lampugnani, che si era inginocchiato di fronte al duca, in segno di (falso)
saluto e omaggio. Questi colpì dal basso verso l’alto, tenendo il pugnale con
la destra e recidendo con ogni probabilità, avendo mirato al basso ventre,
l’arteria femorale sinistra. Il secondo colpo, come lasciatoci detto da Orfeo
Cenni, penetrò invece nello stomaco.
A questo punto, a meno quindi di tre, quattro secondi,
intervennero gli altri due congiurati, con quattro colpi: alla gola dalla parte
sinistra, con quasi certa recisione della arteria giugulare; alla testa, da
sopra, quindi tra osso frontale e parietale; nella zona sopraccigliare dove
pulsa il sangue, cioè in una zona compresa tra l’arcata orbitale sinistra e
l’arteria temporale (e la lama dovette affondare, all’incirca, fino alle fosse
nasali); l’ultimo, nel fianco posteriore della testa.
Per il numero di colpi e la posizione degli stessi, è lecito
pensare che la morte del Duca sopraggiungesse nell’arco di pochi secondi,
sufficienti, tuttavia, per permettere all’Olgiati e al Visconti di allontanarsi
indisturbati dal luogo del delitto, sfruttando il panico e la sorpresa che si
erano ingenerati nella chiesa. Il Lampugnani fu invece immediatamente raggiunto
dalle spade degli sforzeschi, e trovò così immediata morte.
I due fuggitivi vennero comunque arrestati pochi giorni
dopo, processati, e giustiziati nel gennaio seguente.
Tornata una parvenza di calma, ma sopraggiunto presto il
timore che qualcosa di grosso si stesse preparando nell’aria, il cadavere di
Galeazzo fu immediatamente trasportato in sacrestia e spogliato (si contarono
quattordici ferite, otto giudicate mortali), e successivamente abbigliato con
una apposita veste cerimoniale fatta arrivare in fretta e furia dal Castello,
dove alla vedova Bona di Savoia non rimaneva che asserragliarsi e proteggere il
figlioletto Gian Galeazzo, legittimo erede del potere ducale. Non era ancora
chiaro quale piega avrebbe potuto prendere la congiura, e tutto era
teoricamente possibile da parte dei nemici del ducato sforzesco, primo fra
tutti, il re di Francia.
Stante il clima politico tesissimo e i rischi elevati, i funerali si tennero la notte stessa, e al termine il corpo fu portato in Duomo, dove venne tumulato prima che spuntasse l’alba del nuovo giorno. L’inumazione avvenne in una porzione di terreno compreso tra due colonne, evitando di segnalare il posto con indicazioni o altri segni, affinché nessuno potesse rinvenire il cadavere.
E difatti, del corpo di Galeazzo Maria non si seppe più
nulla, proprio come era interesse del fratello Ludovico (il Moro), nei cui
piani vi era quello di usurpare il potere al giovane nipote Gian Galeazzo.
Ma forse qualcuno, e vedremo chi, quel cadavere non solo
ebbe modo di individuarlo, ma addirittura ebbe il permesso (e perchè negarlo,
del resto?) di spostarlo da Milano, per dargli una più degna sepoltura.
Le indagini contemporanee
La soluzione del giallo, quello che ruota attorno al luogo
ove trovò eterno riposo il corpo ducale, ci obbliga a fare un salto di cinque
secoli e a spostarci nella città di Melzo.
Qui, in zona centrale, sorge la chiesa di Sant’Andrea, la
quale, pur essendo le sue origini risalenti all’anno mille, intorno al 1960,
dopo anni di abbandono, rischiò di essere rasa al suolo per lasciare posto ad
un ampio parcheggio. Solo nel 1980, dopo più di un secolo di incuria, ha visto
finalmente una vera rinascita, grazie ad un pregevole restauro voluto e
organizzato da una tenace associazione del luogo.
Durante i lavori di restauro, che hanno tra l’altro messo in
luce l’esistenza di affreschi attribuiti alla scuola di Leonardo, fu rinvenuto,
sotto il pavimento della zona absidale, un cranio di adulto, mal conservato,
frammentato e non completo, che tuttavia accese la curiosità degli operatori.
Datato col carbonio 14, si stabilì il periodo di decesso del
suo proprietario: tra il 1430 e il 1480. Gli esami autoptici rivelarono dati
importantissimi: innanzitutto, l’età, compresa tra i 32 e i 39 anni, il sesso,
maschio, e la razza, caucasica.


Il “caso del cranio senza nome” fu affidato, infine, alla
professoressa Vaglienti, che volle appurare se vi fossero le condizioni
storiche, mediche e scientifiche per poter attribuire il teschio al duca di
Milano Galeazzo Maria Sforza.
Il sospetto di essere in presenza di una parte dei resti del
Duca assassinato nasceva da un fatto storico inconfutabile: l’amante prediletta
di Galeazzo, come già detto, Lucia Marliani, aveva dal Signore di Milano
ottenuto in dono il feudo di Melzo. Non era quindi un’ipotesi troppo ardita
supporre che la donna avesse fatto traslare il corpo dell’amato, padre dei suoi
figli, per inumarlo definitivamente nella chiesa di Sant’Andrea.
L’analisi antropologica e medico-legali del reperto hanno
fin da subito evidenziato due lesioni importanti sulla calotta cranica. Un’area
depressa a stampo, con chiari segni di rimodellamento osseo e avanzata
guarigione, un colpo ricevuto dunque alcuni anni prima della morte,
probabilmente inferto da un corpo contundente avente una superficie battente
piccola. Anche la seconda lesione, sulla parte frontale, presenta simili
caratteristiche: avanzata guarigione, corpo contundente, piccola superficie
battente.
Questi traumi potrebbero coincidere con le lesioni che
Galeazzo Maria si era procurato durante i numerosi duelli e simulazioni di
battaglia che amava ingaggiare con i fratelli Ludovico e Sforza Maria, durante
i quali gli spavaldi giovani non si tiravano certo indietro per forza e
violenza dei colpi, inferti con le migliori armi bianche che l’epoca
conoscesse: lance, mazze d’arme, azze, martelli d’arme, queste ultime tre
tipiche armi da botta e punta. E a nulla valevano le raccomandazioni paterne di
Francesco, di “non schirzare con ferri, sarizi e bastoni”.
Lo studio dei denti rinvenuti ha permesso una dettagliata
analisi della vita del proprietario del cranio. Essi sono apparsi molto usurati
ma sostanzialmente sani e privi di carie, fatto questo coincidente,
innanzitutto, con una adeguata e regolare nutrizione (privilegio dei ceti più
abbienti), ma anche con una ricercata igiene orale, all’epoca basata sulla
pulizia dei denti mediante spazzole in ferro molto abrasive. Sappiamo che
Galeazzo teneva molto ai suoi denti, che manteneva puliti usando, appunto, gli
strumenti (eccessivamente invasivi) in voga presso le persone di altissimo
livello economico.
Si è inoltre scoperta una lieve ipoplasia dello smalto su
canini ed incisivi. L’ipoplasia è un arresto temporaneo della crescita dello
smalto che si depone sui denti nella fase del loro sviluppo. Tale patologia è
data da eventi stressanti che colpiscono il soggetto quando ha tra i sei e i
nove anni (periodo in cui spuntano e si assestano incisivi e canini).
Come riportano i biografi, Galeazzo Maria non ebbe,
in tenera età, una buona salute, e tanto meno lo si trovava in forma all’età di
nove anni, quando soffrì di “febbre terzana doppia”, vale a dire di febbri
ricorrenti malariche, assai diffuse nella penisola italiana.
In quell’occasione, che si protrasse per circa tre settimana
nell’estate del 1453, il futuro duca fu tormentato da febbre alta, sudorazioni
abbondanti e continue epistassi con abbondanti perdite di sangue.
Come appare chiaro, vi sono molti punti di coincidenza tra le caratteristiche del cranio rinvenuto in Sant’Andrea e Galeazzo Maria. Il tentativo di estrarre DNA dalle ossa rinvenute ha purtroppo dato esito negativo, ed è stato perciò impossibile confrontarlo con quello di altri corpi di casa Sforza.
 Si è però voluto tentare la strada della ricostruzione
facciale: partendo dal cranio, si è ricostruito l’ipotetico aspetto che poteva
avere il volto, per poterlo confrontare con i (presunti) ritratti del duca (in
principal modo, con la figura posizionata a sinistra, a cavallo, nel celebre
Corteo dei Magi di Benozzo Gozzoli, che dovrebbe appunto rappresentare Galeazzo
nel 1459, quando era ancora, solo, conte di Pavia). Un paragone può anche
essere fatto con la rappresentazione che il duce si fece fare per il conio del
doppio testone d’argento. Pur trattandosi di una tecnica grossolana e senza
certezze scientifiche (soprattutto per quanto riguarda la ricostruzione di due
elementi determinati per le fattezze di un viso: le labbra e il naso), la
ricostruzione ha permesso un confronto anche con un ritratto di profilo di
Bianca Maria Visconti, e, in un certo senso, si sono potute notare numerose
affinità.
Si è però voluto tentare la strada della ricostruzione
facciale: partendo dal cranio, si è ricostruito l’ipotetico aspetto che poteva
avere il volto, per poterlo confrontare con i (presunti) ritratti del duca (in
principal modo, con la figura posizionata a sinistra, a cavallo, nel celebre
Corteo dei Magi di Benozzo Gozzoli, che dovrebbe appunto rappresentare Galeazzo
nel 1459, quando era ancora, solo, conte di Pavia). Un paragone può anche
essere fatto con la rappresentazione che il duce si fece fare per il conio del
doppio testone d’argento. Pur trattandosi di una tecnica grossolana e senza
certezze scientifiche (soprattutto per quanto riguarda la ricostruzione di due
elementi determinati per le fattezze di un viso: le labbra e il naso), la
ricostruzione ha permesso un confronto anche con un ritratto di profilo di
Bianca Maria Visconti, e, in un certo senso, si sono potute notare numerose
affinità.
Nonostante dunque si possa ritenere molto probabile
l’inumazione del corpo di Galeazzo nella chiesa di Sant’Andrea, elementi certi
sulla fine del corpo del duca non se possono, per ora, avere.
Bibliografia
Vaglienti F.M., Anatomia di una congiura. Sulle tracce
dell’assassinio del duca Galeazzo Maria Sforza tra storia e scienza, in
"Rendiconti dell’Ist. Lombardo Accademia di scienze e lettere", CXXXVI/2, 2002;
Belloni C., Milano in età sforzesca, in Storia illustrata di
Milano, a cura di Franco Della Peruta, vol. III, 1993
Bindelli B., La Zecca e il gabinetto Numismatico di Milano,
cenni storici, 1880
Crippa C., Le monete di Milano dai Visconti agli Sforza dal
1329 al 1535, 1986
Lopez G., I signori di Milano, 2003
Zeppegno L., Le chiese di Milano, 1999
Mauro Colombo
12 ottobre 2005
ultima modifica: dicembre 2014
ultima modifica: dicembre 2014




_-_Vedute_di_Milano_-_05_-_Santo_Stefano_-_ca._1745.jpg)