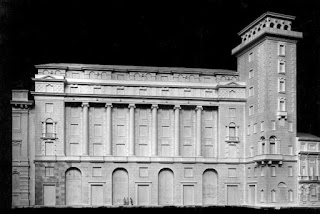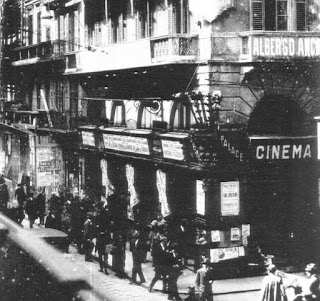I fratelli
Auguste e
Louis Lumière, dopo aver lavorato per anni accanto al padre, rinomato produttore fotografico, iniziarono ad interessarsi alla pellicola cinematografica dal
1892. Ben presto, superati i noti problemi tecnici fino ad allora riscontrati dai pionieri della materia,
brevettarono il
"cinematographe" il 13 febbraio
1895. Pochi mesi dopo realizzarono il loro primo film: "La sortie des usines Lumiere". Pochi secondi, ma entrati nella storia.
La prima proiezione in pubblico avvenne il 28 dicembre dello stesso anno, al Gran Cafè (nel sotterraneo chiamato salon indien), in Boulevard des Capucines, naturalmente a Parigi. Ingresso un franco, 33 spettatori, nessun giornalista benchè invitati. Un mezzo flop, si pensò subito. Tuttavia, il passaparola fece sì che, nell'arco di pochi giorni, già si formassero file di duemila persone pronte ad assistere al prodigio.
In Italia, un ampio resoconto della novità transalpina lo diede il Bollettino mensile del circolo fotografico lombardo. Un'esaustiva spiegazione scientifica, corredata da illustrazioni, aveva incuriosito molto i lettori circa le meraviglie promesse da questo nuovissimo apparecchio. Si faceva notare come tutti i difetti dei precedenti esperimenti in materia (la fotografia in movimento, il fucile fotografico di Janssen, il Kinetografo-Kinetoscopio di Edison) fossero stati finalmente superati. Ora era possibile ammirare su un grande schermo scene in movimento, come una via animata, l'uscita degli operai dalla fabbrica, e altre brevi riprese, quelle all'epoca nel catalogo dei film dei fratelli Lumiere.

A
Milano, il sistema cinematografico Lumiere fu
presentato per la prima
volta presso i locali del
Circolo Fotografico, in
via Principe Umberto
30 (oggi via
Turati).
Era il 29 marzo 1896. Un numero limitato e selezionato di milanesi
potè così assistere alla proiezione delle brevi scene in movimento.
Il giorno seguente, 30 marzo, la nuova forma di intrattenimento fu presentata ad un vero pubblico, quello del
Teatro Milanese, in corso
Vittorio Emanuele 15 (dove poi sorgerà il famoso Hotel Splendid al Corso, con la sotterranea sala
Trianon).
Il Corriere riporta, nel trafiletto dedicato agli spettacoli teatrali, la programmazione del Milanese, segnalandola come "La fotografia animata".
Lo stesso teatro continuò a proiettare per tre mesi e mezzo circa, e dopo una pausa estiva, ricominciò dal 3 settembre.
Durante l'estate, tuttavia, l'invenzione del secolo poteva essere ammirata in altri due teatri: il
Gerolamo di piazza Beccaria, e il
Filodrammatici di piazza Ferrari.

In questo stesso anno,
Italo Pacchioni (che con il fratello aveva aperto in città uno studio fotografico) riuscì a costruire (dopo una proficua gita a Parigi) un apparecchio di ripresa e riproduzione simile a quello dei Lumiere, ma con interessanti modifiche, con il quale riuscì ad attirare un discreto pubblico, presso il suo locale alla
fiera di Porta Genova.

Egli iniziò a girare propri film, che mostravano scene di vita quotidiana milanese, soffermandosi su scorci caratteristici (il
Castello Sforzesco, nel "Finto storpio" - 1896) o
attraverso cerimonie e avvenimenti,
come i funerali di Giuseppe Verdi (1901).
Non solo queste opere entrarono nella storia come le prime produzioni
cinematografiche realizzate nel nostro Paese, ma sono oggi testimonianze uniche di come appariva la città di Milano a fine ‘800.

Dal 1897 in avanti, la "settima arte" (che ormai poteva contare numerosi produttori di film) si diffuse in altri teatri e sale d'intrattenimento milanesi, quali il
Dal Verme, l'
Eden, l'
Alhambra presso l'arco del Sempione.
Nel 1899, il 4 ottobre, una proiezione con apparecchio American Biograph si svolse presso un locale di Palazzo Soncino (Via Torino angolo con omonima via). Qui nascerà poi, nel 1910, la Sala Marconi, che regalava al pubblico pagante proiezioni continue fin dal mattino.

Secondo gli storici, la
prima vera sala cinematografica aperta a Milano è la
Sala Edison di via
Cantù, che tal Ercole Pettini inaugura nel
1904.
E se nel 1907 la
Rivista Fono-cinematografica scriveva che la nostra città contava solo una dozzina di sale, a causa delle proteste di vicini, dei padroni, della vigilanza (mentre a Parigi erano già 120, e Roma 52), dal 1909 iniziarono finalmente a vedere la luce numerose sale cinematografiche, quali il
Garibaldi, il
Centrale in piazza Duomo, sotto i portici settentrionali, il contiguo
Apollo, il Brera in via Solferino, il Napo Torriani in via Torriani angolo via Tenca, alle quali nel 1911 si aggiunse il
Palace di Corso Vittorio Emanuele.
Il nuovo genere d'intrattenimento aveva ormai preso piede: da allora, a Milano apriranno decine e decine di sale (ben 66 nel 1930, anno in cui, peraltro, arrivò il sonoro).
Fu però nel secondo dopoguerra che Milano fu letteralmente invasa da sale cinematografiche, basti pensare che nel 1970 se ne contavano (tra prime, seconde e terze visioni) ben 120.
Per vedere il film di
Pacchioni girato all'interno del
Castello sforzesco nel 1896, clicca
qui
BIBLIOGRAFIA
AA.VV., Il cinematografo, invenzione del secolo, 1994
De Berti R., Un secolo di cinema a Milano, 1996
Sito web: giusepperausa.it
Mauro Colombo
maurocolombomilano@virgilio.it
novembre 2016
 Quasi all'altezza del primo piano della torre, esisteva una nicchia con un altorilievo raffigurante una figura femminile nuda. La trovata del Portaluppi non ebbe largo
apprezzamento, e al montare delle proteste di benpensanti e puritani, scattò la
censura. Si dovette così rimettere mano alla base della torre, e dopo il 1931
nicchia e donna nuda vennero rimosse.
Quasi all'altezza del primo piano della torre, esisteva una nicchia con un altorilievo raffigurante una figura femminile nuda. La trovata del Portaluppi non ebbe largo
apprezzamento, e al montare delle proteste di benpensanti e puritani, scattò la
censura. Si dovette così rimettere mano alla base della torre, e dopo il 1931
nicchia e donna nuda vennero rimosse.